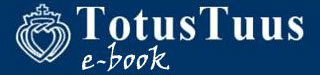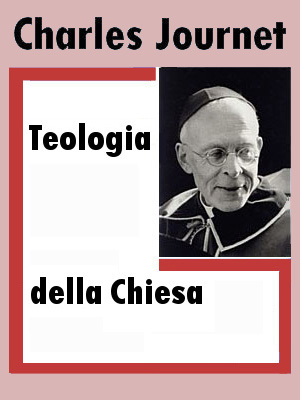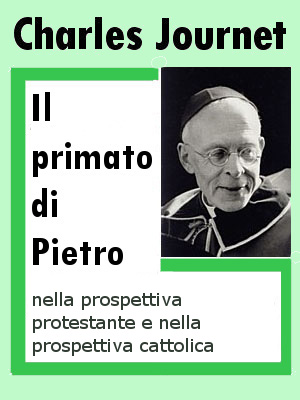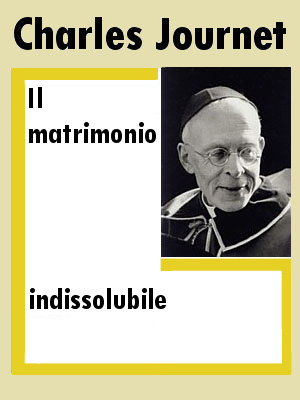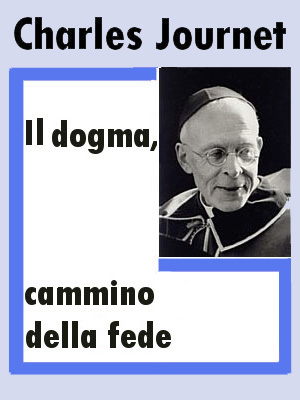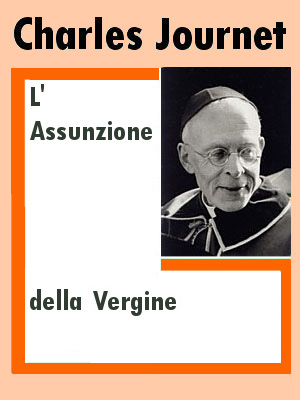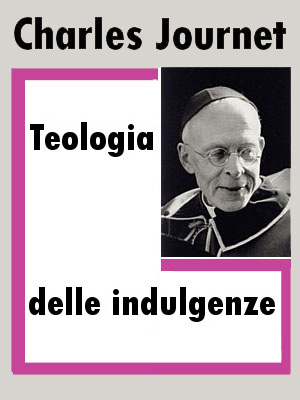“Gli editori di L’Eglise du Verbe incarné mi proposero di fare un compendio di quest’opera, precisamente per i cristiani «molto occupati», o di possibilità economiche piuttosto limitate. L’invito era quanto mai lusinghiero, eppure non ero propenso ad accingermi a tale lavoro, a motivo delle perplessità che poteva suscitare, dello sforzo di riordinamento che richiedeva, e della monotonia – perché non dirlo? – di dover ripresentare esposizioni molto diffuse, senza offuscare, sia pure in piccola misura, un mistero a cui soltanto il silenzio della contemplazione può rendere la sua assoluta semplicità : il mistero della Chiesa, che é la casa di Dio, Cristo diffuso e comunicato, il Vangelo che si continua nel tempo”.
Il primato di Pietro nella prospettiva protestante e nella prospettiva cattolica.
“Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa…” Si provi a trovare, per la parola di Cristo a Pietro, un effetto adeguato che non sia la cattedra di Pietro; e si provi a scoprire, per questa cattedra, una causa sufficiente che non sia la promessa fatta a Pietro.
Presentazione con parole di Giovanni Cantoni:
La conformazione fisiologica del genere umano, la sua suddivisione sessuale, la dicotomia in maschi e femmine indica chiaramente, senza ombra di dubbio, la modalità del perpetuarsi del genere stesso. Tale modalità é l’accoppiamento tra individui di sesso diverso, che, secondo tempi invariati, produce un nuovo individuo, un “piccolo d’uomo”. E il piccolo d’uomo, rispetto ai piccoli di animali, ha un carattere particolare, dal momento che, come ha notato Plinio il Vecchio, é capace di fare una sola cosa: piangere (Storia naturale, l. VII. 1). Da questa considerazione sperimentale, da questa osservazione acutissima si può e si deve partire per impostare in modo corretto il problema del divorzio, piccolo o grande che sia. Il neonato, uomo e futuro cittadino, é frutto di un accoppiamento che – di suo – potrebbe anche essere more pecudum, cioé animalesco, occasionale e dettato da motivazioni meno che nobili.
La fede comporta due aspetti, due luci inseparabili e complementari: la luce profetica di fede che presenta il dato da credere, e la luce santificante di fede, che facendo acconsentire a questo dato, diviene il “fondamento e la radice di tutta la giustificazione” (Concilio di Trento, Sess. VI, cap. 8; Denz., n, 801). E’ proprio la prima luce, senza dubbio meno importante e nondimeno rigorosamente necessaria, senza la quale nessun atto di fede sarebbe possibile – senza la quale la virtù della fede resterebbe addormentata in noi come nel bambino battezzato – che trattiene qui, non certo esclusivamente ma principalmente, la nostra attenzione. Abbiamo tentato di analizzarla fin nei suoi aspetti più nascosti. Poi abbiamo brevemente considerato la maniera del suo sviluppo nell’Antico Testamento e nel periodo apostolico, in cui si esprime in nuove rivelazioni. Infine nell’età post-apostolica, quando, terminata la rivelazione canonica, essa non può dar luogo che a nuove esplicitazioni: al progresso della rivelazione succede allora il progresso del suo sviluppo, al progresso degli articoli di fede il progresso dei dogmi o verità di fede. Era necessario soffermarsi alquanto su tale vertice, dare qualche esempio di sviluppo dogmatico, mostrare come il dogma, senza minimamente infeudarsi ad una cultura, possa talvolta superare il senso comune pur restando in linea con ciò che vi é di più autentico, insistere sul valore di verità assoluta dei principi rivelati, compatibile tuttavia con un progresso nella loro enunciazione, segnalare, senza nominarne gli autori, uno o due casi recenti di deviazione, citare il testo di Giovanni XXIII sul “modo di promuovere la dottrina” e di “reprimere gli errori” nella nostra epoca.
In questo saggio il mistero del male é considerato dal punto di vista teologico. Vi é forse un problema più pressante e che si presenti più inevitabilmente ai credenti?
Lasciando da parte ciò che spetta alle scienze particolari come la biologia, la psicologia, ecc., tratteremo del male in generale, sotto il suo aspetto teologico e filosofico. Una volta posto il problema del male (cap. I), parleremo della sua natura (cap. II), poi delle sue forme (cap. III). Successivamente si presenterà la questione centrale del suoi rapporti con un Dio onnipotente ed infinitamente buono (cap. IV); seguirà la considerazione delle diverse forme del male: male della natura (cap. V); male del peccato, in cui la verità centrale da ristabilire (I) é quella che ogni creatura libera é per natura soggetta al peccato (cap. VI); male delle pene dell’inferno e del purgatorio (cap. VII), e delle pene della vita presente (cap. VIII). Dopo una rapida digressione sul male nella storia (cap. IX), ritorneremo al punto di partenza per decidere come giudicare il male (cap. X).
La Vergine che genera il Figlio unigenito, il quale é il Capo, é il modello o la forma della Chiesa, la quale genera i figli d’adozione, che sono le membra. Essa é il punto d’intensità suprema, al quale bisogna che la Chiesa tocchi una volta nella sua vita, per poter essere quello che deve essere per tutto il resto della sua vita. Maria é così, nella Chiesa, più madre che non la Chiesa, più sposa che non la Chiesa, più vergine che non la Chiesa; é madre, é sposa, é vergine prima della Chiesa e affinché la Chiesa possa esserlo. E’ per una eccellenza misteriosa che si diffonde cominciando da Maria, che la Chiesa può essere, a sua volta, così veramente madre, così veramente sposa, così veramente vergine. Ecco che cosa s’intende dire quando si dice che Maria é il prototipo della Chiesa; tutto il destino della Chiesa é foggiato su quello di Maria. E allora si comprende come la Chiesa non possa progredire nella presa di coscienza del proprio destino, senza avanzare di pari passo nella presa di coscienza del destino della Vergine, dei suoi dolori e delle sue grandezze.
Le verità della dottrina cristiana non si pongono sul medesimo piano. Esse sono tra loro disposte in ordine gerarchico. Avviene ciò che accade in un albero, nel quale si distinguono le radici, il tronco, i rami, le fronde; o come nel corpo umano, dove si distinguono il cuore, le arterie, i vasi capillari. La dottrina delle indulgenze é simile alle fronde di un albero, ai vasi capillari dell’uomo. E’ una dottrina secondaria. Essa é apparsa nel corso dei secoli e in Occidente, come i ramoscelli di un albero vigoroso e delicato a un tempo. E’ potuta rimanere lungo tempo non conosciuta, non manifestata. Non correva alcun pericolo rimanendo tale. Ma succederebbe altrimenti quando, una volta manifestatasi nella sua verità , incominciasse ad essere volutamente ignorata, rifiutata, respinta. L’essiccarsi dei ramoscelli più periferici di un albero, la disfunzione dei vasi capillari non sono di per sé disastrosi, ma preoccupano il coltivatore o il medico perché possono essere l’indizio di disordini nefasti e più nascosti.